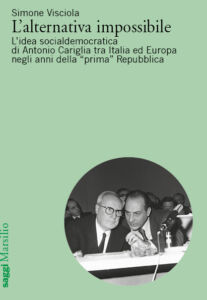Nell’ultimo numero della rivista Nuova Storia Contemporanea (ed. Le Lettere) una recensione firmata da Paolo Buchignani, storico dell’Italia contemporanea, del volume «L’alternativa impossibile. L’idea socialdemocratica di Antonio Cariglia tra Italia e Europa negli anni della “prima” Repubblica», scritto da Simone Visciola e pubblicato da Marsilio editore nel 2020.
“Nel mondo occidentale i socialdemocratici non hanno distrutto la ricchezza, ma l’hanno distribuita, tant’è vero che solo in Europa occidentale c’è una serie di presidi sociali che nessuna democrazia al mondo ha. Questa è la parte del mondo dove l’uomo, il cittadino, l’impiegato è meglio garantito rispetto ad ogni altro tipo di sistema politico, questa è la parte del mondo dove si sta meglio, dove si può affrontare l’avversità della disoccupazione, delle malattie, ma sotto una copertura sociale che altri paesi non hanno, e questo è il frutto del riformismo socialista, della socialdemocrazia, del concetto elementare secondo il quale la ricchezza andava favorita nella sua crescita, ma meglio distribuita in nome di valori etici che sono la nostra forza”.
Così scriveva, nel febbraio1992, Antonio Cariglia, l’ultimo segretario di un PSDI ormai morente assieme alla “prima” Repubblica; un partito lacerato dalle divisioni e travolto dalle inchieste giudiziarie di Tangentopoli, dalle quali, tuttavia, l’uomo politico pistoiese uscirà del tutto indenne, ma soltanto nel 2004, quando sarà assolto con formule piena da tutte le accuse.
La citazione di cui sopra è contenuta nel corposo e interessante volume dedicato al leader socialdemocratico da Simone Visciola, giovane storico dell’età contemporanea, docente presso l’Université de Toulon. Appartenente alla generazione formatasi dopo il 1989, quella cosiddetta “post-ideologica”, lo studioso affronta l’argomento in modo oggettivo e rigoroso, sforzandosi anche di dare alla narrazione un taglio più divulgativo che accademico.
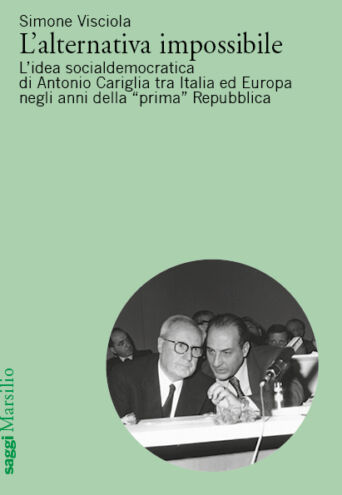
Per quanto oggi, in un tempo di risorgenti nazionalismi e populismi, anche la proposta socialdemocratica sia entrata in crisi e necessiti almeno di un aggiornamento, di una rivisitazione per dare adeguate risposte ai disagi e alle contraddizioni indotte dalla globalizzazione e dal neoliberismo sfrenato, è difficile dar torto a questa analisi di Cariglia: la storia del ‘900, dal “biennio rosso” di un secolo fa all’estremismo sessantottino con la deriva terroristica, dagli orrori dello stalinismo al crollo del socialismo reale, ha segnato, con tutta evidenza, la vittoria del riformismo sul massimalismo, tra Filippo Turati, Giacomo Matteotti e Claudio Treves da un lato, Gramsci, Togliatti, Bordiga e Serrati dall’altro, senza dubbio ha dato ragione ai primi.
Anche, possiamo aggiungere, se ci riferiamo all’Italia del secondo dopoguerra, ha dato ragione a Giuseppe Saragat e al suo allievo e stretto collaboratore Antonio Cariglia, che nel 1947 con la scissione di Palazzo Barberini, staccandosi da un partito socialista di indubbia impronta staliniana e schierandosi senza incertezze con l’Occidente, fecero, in quel drammatico contesto, una scelta fondamentale e lungimirante per il futuro del Paese, dimostrando, coi fatti, la fedeltà ad una concezione del socialismo inscindibile dalla libertà e dalla democrazia.
Come Saragat, Cariglia, punto di riferimento politico e morale dei socialdemocratici italiani dopo la morte del maestro, per tutta la sua vita, si è battuto con ostinazione e coraggio per costruire in Italia una grande forza socialista, democratica e laica alternativa sia alla DC che al PCI, una forza in grado di sbloccare un sistema politico forgiato, dal 1948, sull’asse fra questi due partiti.
Dopo aver svolto una intensa attività sindacale, il leader socialdemocratico è stato, per molti anni, l’unico rappresentante italiano al Bureau dell’Internazionale socialista, a cui ha cercato di far accedere prima il PSI, poi, più tardi, anche gli eredi del PCI, ossia il PDS, convinto che, con la caduta del Muro di Berlino e la fine dell’URSS, si fossero create le condizioni per dare corpo al disegno da sempre caldeggiato: la edificazione di una “Casa comune” di tutta la sinistra italiana, approdata definitivamente alla libertà e alla democrazia, una sinistra che si ispirasse al programma di Bad Godesberg, che egli aveva accolto con entusiasmo interpretandolo come l’ennesima conferma della validità della scelta compiuta a Palazzo Barberini.
Per lungo tempo deputato e senatore nel Parlamento italiano, poi eletto in quello europeo, il politico pistoiese non ha mai cessato di battersi per questo obiettivo.
L’unificazione coi socialisti di Nenni gli sembrò a portata di mano nel 1956, quando questi ultimi si sciolsero dal Fronte popolare col PCI di Togliatti, e Saragat inviò proprio lui a Londra a perorare l’ingresso del PSI nell’Internazionale socialista. A quella unificazione si arrivò nel 1966, ma fu una esperienza di breve durata. Cariglia ci provò ancora nel 1988, quando ascese alla segreteria del partito, ma ormai, come si è detto, il PSDI, lacerato da lotte intestine, sinistrato dagli scandali (ben tre segretari prima di lui indotti alle dimissioni da vicende giudiziarie), non aveva futuro.
Visciola opportunamente si interroga sulle ragioni che hanno impedito alle idee socialdemocratiche di Saragat e Cariglia di affermarsi in Italia, mentre quelle stesse idee, quello stesso progetto politico si sono imposti con successo in diversi paesi europei, dove, specialmente nel corso degli anni ’60 sono riusciti a garantire un felice equilibrio tra un massimo di libertà e un massimo di giustizia sociale. Una domanda fondamentale, questa, che impone una profonda riflessione sulla storia italiana e specialmente su quella degli ultimi due secoli.
Una domanda che si pone tutt’oggi alla luce della realtà odierna e alla quale lo stesso Cariglia, nel 1992, aveva provato a rispondere. Una risposta che si colloca nel solco della tradizione riformista da Turati in poi e la cui validità, col passare dei decenni, sembra emergere con sempre maggiore evidenza. L’autore del volume, in una delle pagine conclusive, ne sintetizza gli elementi peculiari:
“Qui Cariglia toccava un aspetto d’importanza storica. L’alternativa socialdemocratica non si era potuta mettere alla prova in Italia, in ragione dell’incidenza di fattori differenti: in primo luogo, andava considerata la natura particolare del capitalismo italiano, definito da Cariglia […] come ‘il più protetto in assoluto’ tra tutti i capitalismi del mondo occidentale, a cui si abbinava la diffidenza che le classi dirigenti avevano da sempre nutrito intorno al possibile accesso delle masse lavoratrici alla guida dello Stato. In secondo luogo, il problema andava individuato nella scarsa cultura riformista delle forze di sinistra – che delle masse lavoratrici erano le rappresentanze – le quali, su un piano in verità più retorico che concretamente incisivo, alimentarono, nel corso della loro storia, il mito della rivoluzione quale unica chiave d’accesso al potere. Un mito potente, che conobbe un processo di straordinario radicamento non solo nell’immaginario delle classi lavoratrici, ma anche, in senso opposto, in quello del ceto dirigente sentitosi ‘minacciato’. La forza di questo mito fece sì che, da una parte le masse lavoratrici rappresentassero per lungo tempo lo Stato come un corpo “alieno”, guardandolo con ostilità e sfiducia, e che, dall’altra, il ceto dirigente maturasse un sentimento di diffidenza e di paura, serrando ancor più i ranghi e operando a respingere la domanda di protagonismo politico delle masse stesse” (cfr. p.399).
L’esito di questa dinamica fu la nascita e il rafforzamento di un regime “bloccato”, privo cioè di un’alternativa di governo.
Come ha scritto, a questo proposito, Massimo Salvadori, “la chiusura delle classi dirigenti e quella delle classi subalterne si saldarono in tal modo reciprocamente, sbarrando la strada alla socialdemocrazia, la quale, cresciuta rigogliosamente in tanta parte d’Europa, rimase [in Italia] una pianta asfittica”.
L’analisi della realtà italiana da parte di Antonio Cariglia coincide quasi in toto con quella di Bettino Craxi e anche il disegno politico dei due leader presenta notevoli affinità: entrambi si richiamano alla lezione di Saragat, entrambi puntano alla creazione di una grande forza socialdemocratica alternativa alla Dc e al PCI e allo sblocco del sistema politico consociativo, entrambi sono favorevoli al superamento della partitocrazia e ad un rafforzamento del ruolo del governo, anche se il primo, a differenza del secondo, è contrario ad una riforma costituzionale in senso presidenziale e propone l’elezione in Parlamento del Presidente del Consiglio e l’introduzione della sfiducia costruttiva.
Se così stanno le cose, perché allora i due leader e i rispettivi partiti non s’incontrano, ma configgono? Essi si contendono l’eredità di Saragat e lo stesso spazio politico. Craxi mira ad assorbire il PSDI, mentre Cariglia non intende lasciarsi fagocitare e aspira, come già in passato, ad uno stretto coordinamento tra le due formazioni politiche che devono rimanere distinte.
Insomma, ancora una volta, il tentativo di far nascere in Italia una grande forza riformista e socialdemocratica naufraga e i due partiti che avrebbero dovuto costituirne il perno finiranno travolti insieme alla “prima Repubblica”.
Questo studio di Simone Visciola, molto documentato e corredato da un’ampia selezione di interventi parlamentari di Cariglia, più che una biografia completa di quest’ultimo, vuole essere, come l’autore stesso dichiara, “il tentativo di inquadrare sul piano storico la visione politica, la progettualità e la tensione prospettica di un uomo […] che dedicò tutta la propria esistenza al perseguimento e alla realizzazione di un’idea”.
Un tentativo senz’altro riuscito, un significativo contributo alla conoscenza del socialismo italiano coi suoi problemi e le sue contraddizioni e, di conseguenza, alla storia del nostro Paese nella seconda metà del Novecento.